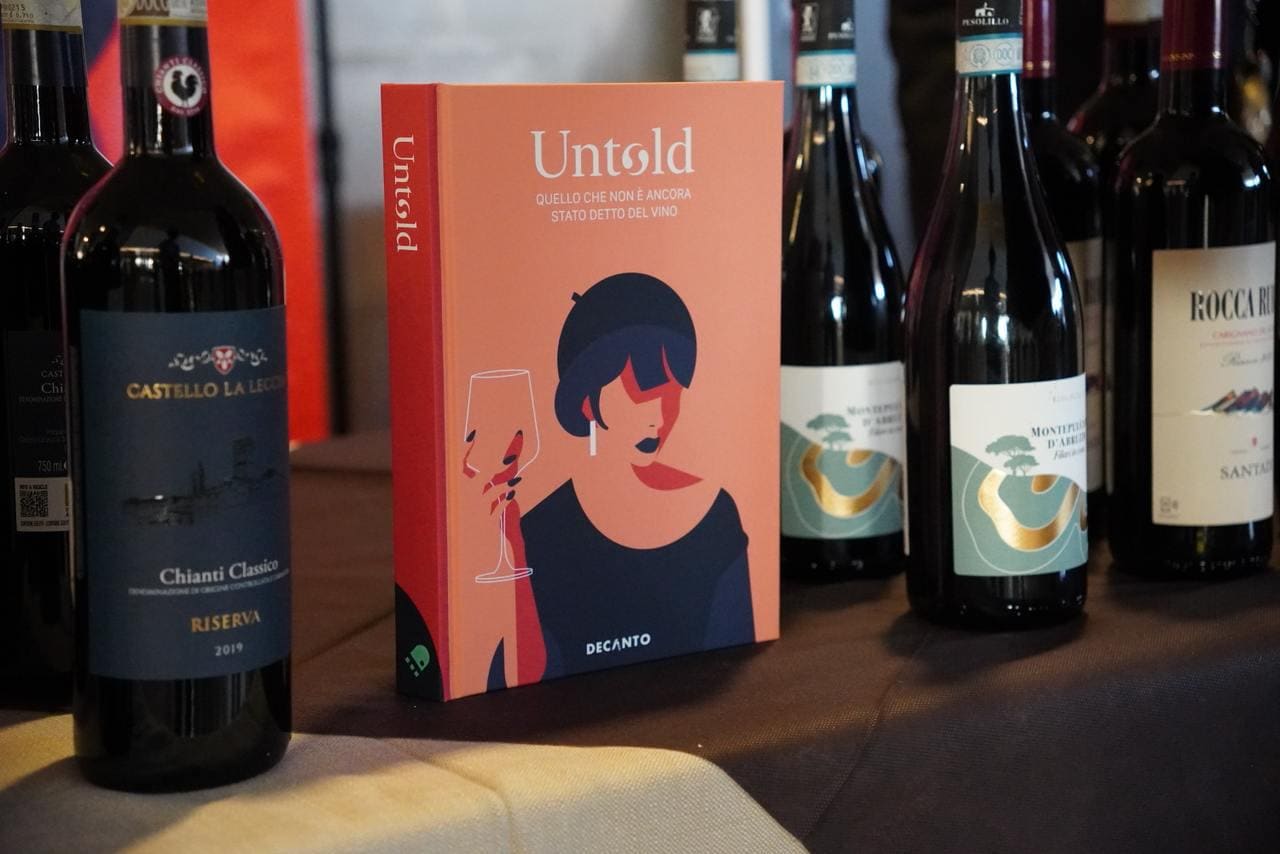Oggi ripercorreremo insieme le fantastiche pagine della storia d’amore più longeva e romantica del mondo. Qualcuno di voi starà già pensando a Romeo e Giulietta, Catullo e Lesbia, Dante e Beatrice… Siete fuori strada, la storia d’amore più famosa dell’umanità è quella che lega l’uomo alla vite. Una storia fatta di speranze e delusioni, di violente malattie e di innovative cure. In questo articolo, pertanto, ripercorreremo i momenti salienti della storia della viticoltura tra piede franco e fillossera sino alle innovazioni dell’età moderna.
Storie di “vite”: la viticoltura attraverso i secoli
La storia del vino si intreccia profondamente con quella della civiltà umana, risalendo alla Preistoria e sviluppandosi attraverso i millenni. Le prime tracce della vite coltivata si trovano in diverse regioni del mondo: in Cina, ad esempio le prime evidenze risalgono al 7.000 a.C., in Georgia all’8.000 a.C., in Iran al 5.000 a.C., in Grecia al 4.500 a.C. e in Sicilia al 4.000 a.C. La più antica cantina conosciuta, risalente al 4.100 a.C., è stata scoperta in Armenia, testimoniando come il vino fosse già un prodotto importante per le civiltà antiche.
Origini della viticoltura
Le prime prove della coltivazione della vite e della produzione vinicola emergono nel Neolitico, un periodo caratterizzato dalla transizione dell’uomo da uno stile di vita nomade a uno sedentario. La coltivazione della vite potrebbe essere nata accidentalmente, quando i primi uomini scoprirono che l’uva lasciata a fermentare spontaneamente produceva una bevanda inebriante.
Le più antiche evidenze chimiche della vinificazione provengono dall’attuale Iran e dal Caucaso (Georgia, Armenia e Azerbaigian), dove in vasi di terracotta sono stati trovati residui di vino risalenti al 5.500-5.000 a.C. Analisi chimiche hanno identificato la presenza di bitartrato di potassio, un segno inequivocabile del processo di fermentazione.
Una scoperta di grande rilievo è avvenuta nel 2007, in Armenia, dove sono stati rinvenuti strumenti per la produzione del vino, tra cui una pressa d’argilla e grandi contenitori per il mosto. Datati a circa 6.100 anni fa, questi reperti confermano l’esistenza di una produzione vinicola organizzata e su scala significativa già nel IV millennio a.C. Scoperta ancor più sensazionale è rappresentata dai semi d’uva trovati nel sito appartenenti alla Vitis vinifera, la stessa varietà utilizzata ancora oggi.
Ruolo del vino nell’antico vicino Oriente e in Egitto

Nel corso dei millenni, il vino divenne un prodotto centrale nella cultura e nell’economia delle antiche civiltà del Vicino Oriente. Scavi in Iran, nella piana di Kangavar, hanno rivelato giare contenenti tracce di vino databili tra il 3.500 e il 3.100 a.C., accompagnate da strumenti per la vinificazione, come bacili d’argilla, imbuti e presse rudimentali per l’estrazione del mosto.
Anche in Palestina, la viticoltura ha radici molto antiche, qui infatti sono stati trovati semi di vite coltivata risalenti al 4.000 a.C., mentre in siti come Gerico sono stati scoperti frutti d’uva carbonizzati.
In Egitto, il vino giocò un ruolo fondamentale nei riti religiosi e nella vita quotidiana fin dal VI millennio a.C. grazie ai fiorenti commerci. Le prime rappresentazioni della vinificazione appaiono nei bassorilievi del III millennio a.C., mentre anfore contenenti vino sono state trovate nelle tombe dei faraoni, tra cui quella di Tutankhamon.
Uno dei vini più pregiati dell’Antico Egitto era lo Shedeh, un vino rosso particolarmente apprezzato. Secondo Plutarco, prima del regno di Psammetico I (VII secolo a.C.), i faraoni evitavano di bere vino, poiché lo consideravano il “sangue dei nemici caduti in battaglia”, un’idea che conferisce una dimensione mistica alla bevanda.
Vino nella culla della civiltà: tra Mesopotamia e Fenici
Nel III millennio a.C., il vino si affermò anche in Mesopotamia, dove era considerato una bevanda di lusso, riservata ai sacerdoti e alla nobiltà. Le tavolette ritrovate a Ebla (Siria), datate al 2.300 a.C., testimoniano un’economia basata sulla produzione di vino e olio d’oliva.
I Fenici, celebri mercanti e navigatori, furono tra i principali diffusori della viticoltura nel Mediterraneo. Essi esportavano le loro anfore vinicole, caratteristiche per la forma allungata, fino in Spagna, influenzando le future produzioni vinicole greche e romane.
Grecia e riti dionisiaci
In Grecia, il vino divenne un pilastro della cultura già in epoca minoica e micenea (III-II millennio a.C.). La bevanda era legata al culto di Dioniso, il dio della fertilità e dell’ebbrezza, e veniva consumata nei simposi, riunioni aristocratiche caratterizzate dalla mescolanza di vino e discussioni filosofiche.
I Greci produssero diverse varietà di vino, tra cui la Retsina, il cui sapore unico derivava dalla resina di pino utilizzata per sigillare le anfore. Esportavano i loro vini in tutto il Mediterraneo e svilupparono tecniche avanzate, come l’aggiunta di gesso per ridurre l’acidità. Il vino dell’isola di Chio era considerato il più pregiato.
Innovazioni romane nella produzione
Con i Romani, il vino divenne una bevanda di massa. A partire dal II secolo a.C., la viticoltura si diffuse in Gallia, Spagna e Germania, grazie alle legioni romane. I Romani perfezionarono l’uso delle botti in legno e delle anfore sigillate con pece per la conservazione del vino. Plinio il Vecchio, nel suo Naturalis Historia, descrive numerose varietà di uve e tecniche di vinificazione.
Dal Medioevo al Rinascimento: la rinascita del vino

Dopo il crollo dell’Impero Romano, i monaci medievali mantennero viva la viticoltura nei loro monasteri, dove il vino era necessario per la liturgia cristiana. Nel XV secolo, le esplorazioni geografiche permisero la diffusione della vite nel Nuovo Mondo: i conquistadores spagnoli impiantarono i primi vigneti in Messico, Cile e Argentina.
Storia del viticoltura dal Rinascimento alla prima metà dell’800
Il Rinascimento fu un periodo di grande rinnovamento culturale, artistico e sociale, nato in Italia, in particolare a Firenze, e diffusosi poi in tutta Europa tra la metà del Quattrocento e la fine del Cinquecento. Anche la vitivinicoltura conobbe importanti sviluppi: le terre coltivate a vite si espansero, grazie all’abbandono della servitù della gleba e alla diffusione della mezzadria, che garantiva stabilità ai contadini. Il commercio favorì la selezione di vitigni più produttivi, aumentando il consumo di vino, già diffuso nel Medioevo.
Miglioramento della tecnica vinicola

Sul piano economico, la coltivazione della vite divenne sempre più vantaggiosa, grazie alla crescita della popolazione e al miglioramento delle condizioni economiche. Dal punto di vista tecnico, la vinificazione nel Rinascimento prevedeva fermentazioni molto lunghe, che conferivano ai vini una forte carica tannica e acidità volatile. Tuttavia, in Francia iniziarono a svilupparsi metodi di fermentazione più controllati, portando alla nascita di vini più delicati e piacevoli.
Si cominciò inoltre a distinguere tra vinificazione in bianco e in rosso, anticipando le moderne pratiche enologiche. Questi progressi aprirono la strada alle scoperte scientifiche successive: Antonie-Laurent de Lavoisier studiò la trasformazione del glucosio in alcol e anidride carbonica, mentre Louis Pasteur chiarì il ruolo dei microorganismi nella fermentazione, segnando l’inizio dell’enologia moderna.
Viticoltura nel Cinquecento
Nel Cinquecento, grazie all’invenzione della stampa e alla diffusione della cultura, si assiste a un grande sviluppo della trattatistica vitivinicola. Studiosi ed editori riscoprono e pubblicano le opere di autori classici come Columella, Plinio il Vecchio e Varrone in raccolte denominate Libri de re rustica, mentre il formato maneggevole e i costi contenuti rendono le Geoponicae, testi di tradizione greco-bizantina, tra i più diffusi.
Uno degli autori più rilevanti dell’epoca è Agostino Gallo, che nelle Dieci giornate dell’agricoltura dedica ampio spazio alla viticoltura e introduce la produzione dei vini frizzanti. Il gusto del vino italiano in epoca rinascimentale cambia anche grazie all’influenza francese, che impone metodi di vinificazione più rapidi per evitare l’eccessiva estrazione di tannini e componenti amare.
Lavoro di Sante Lancerio e Andrea Bacci
Nel tardo Cinquecento, Sante Lancerio, bottigliere di Papa Paolo III Farnese, classifica i vini in base a criteri qualitativi e sociali, precorrendo il linguaggio enologico moderno.
Andrea Bacci, nel De naturali vinorum historia (1596), realizza il primo grande atlante dei vini d’Italia, analizzandone le caratteristiche, le tecniche di produzione e il rapporto con la salute. Egli anticipa il concetto di Denominazione di Origine, affermando che il vino è espressione del suo territorio.
Vino in medicina
Nel corso della storia, il vino è stato considerato non solo una bevanda di qualità e un alimento, ma anche una vera e propria medicina. Nell’epoca prescientifica, veniva usato per curare numerosi disturbi, dalla febbre alla costipazione, fino all’anemia. Diverse ricette lo combinavano con erbe e spezie per aumentarne gli effetti curativi, come il vino bianco con assenzio per l’itterizia o il broulé per il mal di gola.
Nel Medioevo e nel Rinascimento, il vino era analizzato secondo la teoria dei quattro elementi e delle qualità (caldo, freddo, umido, secco), e il suo consumo era regolato più da principi sanitari che da motivazioni morali o religiose. Medici come Michele Savonarola lo consideravano benefico se assunto con moderazione, valutandone il calore in base al colore, all’odore e all’età del vino. Baldassarre Pisanelli, nel suo trattato, metteva in guardia dagli eccessi: il vino troppo invecchiato era più adatto a scopi medicinali, mentre quello giovane poteva generare effetti negativi sull’umore e sulla digestione.
Nel XVI secolo, Andrea Bacci pubblicò un’opera che classificava sistematicamente le conoscenze sul vino, includendone gli usi terapeutici. Anche nei secoli successivi, il vino continuò a essere impiegato in farmacopea, spesso mescolato con erbe e sostanze medicinali per creare vini medicati o teriache. Esempi di rimedi includono il vino con rosmarino per migliorare l’appetito e il benessere mentale o quello con lingua di manzo per curare disturbi psichici. Con l’avanzare della scienza nel XIX secolo, il vino perse progressivamente il suo ruolo come cura universale, ma mantenne una reputazione positiva per i suoi effetti benefici sull’organismo.
Introduzione della viticoltura nel Nuovo Mondo

Le scoperte geografiche dell’Età Moderna favoriscono la diffusione della vite in tutto il mondo, grazie alle esplorazioni portoghesi e spagnole del XV e XVI secolo. La colonizzazione delle Americhe porta alla rapida espansione della viticoltura, con particolare attenzione alla produzione di vino per esigenze liturgiche.
In America Latina, la Spagna promuove la coltivazione della vite, e nel 1524 Cortés ordina la piantagione obbligatoria di viti nelle nuove terre conquistate. Tuttavia, nel tardo XVI secolo, Filippo II vieta l’impianto di nuovi vigneti per limitare la concorrenza con la produzione spagnola.
In Nord America, la Vitis riparia cresce spontaneamente, ma ha un basso potenziale vinicolo rispetto alla Vitis vinifera europea. I missionari tentano di produrre vino da queste viti selvatiche, ma senza successo. Solo nel XVIII secolo la viticoltura si sviluppa in California, grazie ai frati francescani.
Conservazione, affinamento e commercio del vino
L’Età Moderna segna l’inizio di importanti sviluppi nelle tecniche di produzione e conservazione del vino. Uno dei maggiori progressi è l’introduzione della bottiglia di vetro. In passato, il vino veniva conservato in botti, ma la sua durata era limitata a causa della rapida degradazione.
Nel XVI secolo, gli spagnoli tentarono di migliorare la stabilità dei loro vini, come lo Sherry, rafforzandoli con brandy e favorendo la crescita di lieviti. Nel XVII secolo, la chiusura delle bottiglie con tappi di sughero rivoluzionò la conservazione del vino, permettendo la sua maturazione a lungo termine.
Durante questo periodo, nacquero anche nuovi tipi di vino, come lo Champagne, grazie al monaco benedettino Dom Pierre Pérignon, che sviluppò tecniche di vinificazione innovative.
Enogastronomia e ruolo del vino nelle tavole rinascimentali
Nel periodo compreso tra il Basso Medioevo e il Rinascimento, e fino alla Rivoluzione Francese, il vino era considerato un bene di lusso, apprezzato da tutte le classi sociali, ma consumato principalmente dalle élite. Durante i banchetti rinascimentali, il servizio del vino era curato da figure specializzate come lo Scalco e il Coppiere. La scoperta dell’America ampliò l’offerta di bevande, con nuovi prodotti come cioccolato, rum, caffè e tè, che iniziarono a competere con il vino.
Ottocento e rilancio del vino

Nel XIX secolo, il vino vive un periodo di rilancio grazie alla ricerca della qualità. L’industrializzazione segna l’evoluzione della metallurgia e delle macchine, come quelle a vapore e frigorifere, che migliorano la produzione e il commercio del vino.
A metà del secolo, la scienza inizia a influenzare la viticoltura, grazie agli studi in microbiologia, chimica enologica e biologia. Lavoisier e Pasteur compiono importanti scoperte, ponendo le basi per una vinificazione più scientifica. Le Esposizioni Universali, a partire dal 1851, giocano un ruolo chiave nella diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con la Francia come promotrice di eventi che favoriscono l’innovazione nel settore vitivinicolo.
Fillossera: la piaga che devastò l’Europa
Come tutte le storie d’amore, anche quella tra l’uomo e la vite ha attraversato fasi di grande difficoltà, proprio nel momento in cui sembrava che tutto fosse finalmente perfetto. La tragedia ebbe inizio in Francia, quando tra il 1860 e il 1870 le campagne vivevano un periodo particolarmente florido. Gli occhi si perdevano nelle valli di vigne, costellate da fattorie prosperose, dove lavoravano contadini con piccoli appezzamenti così come grandi latifondisti. La viticoltura sembrava aver sconfitto il grande nemico dell’epoca: l’oidio, una malattia che aveva messo a repentaglio le coltivazioni, e la produzione di vino andava a gonfie vele. La rete ferroviaria, appena costruita, aveva abbattuto i costi di trasporto, mentre l’aumento dei salari nei centri urbani aveva accresciuto il potere d’acquisto di milioni di persone. Il vino, ormai, era entrato nelle case anche di chi non viveva nelle zone vinicole, come la regione parigina o quelle del nord.
Era davvero un momento d’oro per la viticoltura. La superficie delle vigne francesi aveva raggiunto i 2,5 milioni di ettari e i rendimenti aumentavano, incentivati dall’impennata dei prezzi e dal calo dei costi di produzione. Le terre avevano acquisito valore e, persino, alcuni operai provenienti dalle fabbriche erano tornati a lavorare nei campi. In quegli anni, la Borgogna e la regione di Bordeaux divennero il simbolo delle grandi tenute vinicole, gli Châteaux, che avrebbero dominato il panorama dei vini a livello mondiale. Un esempio fulgido di questo splendore è la tenuta Château Lafite, che nel 1861 venne acquistata dalla famiglia Rothschild per ben quattro milioni di franchi – un valore che nel 1821 era di appena uno. Ma come in ogni fiaba, un’ombra si stava facendo strada nel cuore di quella luce.
Arrivo della fillossera in Europa

Nel 1863, a Pujaut, vicino ad Avignone, una vigna seccò misteriosamente e morì, senza destare preoccupazioni. Ma il fenomeno si diffuse, seppur in piccole aree, senza destare grande allarme. Fino al 1868, quando il professor Jules Émile Planchon giunse a una conclusione tragica: la causa era un parassita sconosciuto in Europa, la fillossera, un afide giallastro originario del Nord America che si nasconde sottoterra, attacca le radici e le fa marcire in un periodo che varia dai tre ai cinque anni. Il suo arrivo segnò l’inizio di una catastrofe che, nel corso di mezzo secolo, avrebbe spazzato via quasi tutte le vigne europee.
Origini della fillossera in America
La fillossera non era una novità assoluta. In America, essa esisteva già da molti anni, ma lì non aveva avuto le stesse conseguenze devastanti. In effetti, nelle viti americane il parassita danneggiava solo le foglie, dove creava galle contenenti le sue uova. Le viti locali, infatti, si erano adattate all’insetto, sviluppando una resistenza che impediva al parassita di attaccare le radici. La grande vulnerabilità della vite europea risiedeva, invece, proprio nel suo apparato radicale, facilmente aggredibile dalla fillossera, che comprometteva l’assorbimento e favoriva l’infezione da parte di altri patogeni, innescando un processo che portava alla morte della pianta nel giro di pochi anni.
Meccanismo di azione della fillossera
La fillossera è un parassita che attacca sia le radici che le foglie della vite. Le radici infette si gonfiano, formando grosse galle che compromettono la capacità della pianta di assorbire acqua e nutrienti. Sulle foglie, l’infestazione genera escrescenze irregolari che rendono difficoltoso il passaggio dei nutrimenti. Il ciclo di vita dell’insetto è complesso: un uovo deposto sotto la corteccia della pianta schiude una fondatrice che, a sua volta, deposita circa 500 uova. Le larve si spostano sulle radici, danneggiandole ulteriormente.
Diffusione della fillossera
Il parassita arrivò in Europa nel corso della prima metà dell’Ottocento, importato insieme a varietà americane di vite come la Isabella e la Catawba, resistenti all’oidio, altro flagello terribile appena sconfitto. Non appena le barbatelle infette furono introdotte in Francia, il parassita cominciò a diffondersi rapidamente, approfittando della vulnerabilità delle viti europee.
La situazione divenne così drammatica che in pochi anni, l’infestazione si estese in tutta Europa. In Italia, la fillossera fece la sua comparsa nel 1879, inizialmente al nord, e poi al sud, in particolare in Sicilia. Ma anche Austria, Germania, Spagna e Portogallo non furono risparmiate, e nel 1914, in una nota del dottor Grandori, si prevedeva che la pestilenza avrebbe superato le valli e le montagne.
Rimedi e soluzione finale alla fillossera
Numerosi rimedi furono tentati per fermare la piaga, ma nessuno ebbe effetto significativo. Si passò dalla sommersione dei vigneti all’uso di insetticidi, ma i risultati furono insufficienti. Solo quando si comprese che alcune specie di viti americane sviluppavano radici immune alla fillossera, si trovò una soluzione definitiva. Il lavoro di Thomas Volney Munson, un ampelografo texano, fu fondamentale: grazie alla sua ricerca, fu possibile innestare le viti europee sulle radici resistenti delle viti americane. Questo innovativo portinnesto permise alla viticoltura di riprendersi dalla devastazione, ma a un prezzo altissimo. Il paesaggio vinicolo europeo fu radicalmente trasformato, e migliaia di varietà autoctone scomparvero.
La fillossera non solo causò danni economici enormi, ma segnò anche una profonda trasformazione sociale, poiché molte famiglie di viticoltori furono costrette a vendere le proprie terre o a emigrare. Tuttavia, la rivoluzione dell’innesto salvò la viticoltura mondiale e avviò una nuova era per la coltivazione della vite, che, pur attraverso un prezzo di sofferenza, divenne moderna.
I sopravvissuti: tra piede franco, terreni sabbiosi e terreni vulcanici

Da tutta questa immane devastazione però, oltre l’intelligenza umana nel creare l’innovazione dell’innesto americano, alcune piante riuscirono a resistere. La magia della natura, il tocco divino e la resilienza hanno fatto si che alcune viti europee sopravvivessero e arrivassero sino ai nostri giorni grazie ad uno scudo naturale creato dal terreno.
Significato di piede franco
In questo stravolgimento mondiale dovuto all’afide è necessario fare ordine cercando di capire cosa significa a piede franco. Tale termine si riferisce a una vite che cresce sulle proprie radici originarie, senza essere innestata su un portainnesto di un’altra varietà. Questa caratteristica, oggi rara, ha una grande importanza storica e qualitativa nella viticoltura.
Come è facilmente intuibile da quanto scritto sino ad adesso, fino alla seconda metà dell’Ottocento, prima dell’arrivo della fillossera, tutte le viti europee erano a piede franco. Nonostante oggi l’innesto sia diventato la prassi, alcune viti a piede franco sono sopravvissute o vengono ancora coltivate in specifiche condizioni ambientali che impediscono alla fillossera di proliferare.
Le viti a piede franco sono spesso considerate preziose per la loro autenticità e la loro capacità di esprimere il terroir in modo più puro. Poiché non passano attraverso il filtro del portainnesto, alcuni esperti ritengono che i vini ottenuti da queste viti abbiano caratteristiche organolettiche più nitide e una maggiore fedeltà alle caratteristiche varietali originarie.
Esempi celebri di vitigni coltivati a piede franco includono i vigneti centenari di Santorini (Grecia), quelli della Sardegna, della Sicilia (come i terreni sabbiosi di Marsala e quelli vulcanici dell’Etna) e alcune zone della Champagne e della Borgogna, dove si trovano ancora rare parcelle risparmiate dalla fillossera.
Terreni vulcanici
Ed ecco che in questo panorama di resilienza si collocano i terreni vulcanici, dove quasi per miracolo la fillossera non è mai arrivata o, perlomeno, non è mai riuscita a devastare i vigneti. Tale incapacità dell’afide di attaccare le vigne sui suoli vulcanici è dovuto principalmente all’elevata presenza di sabbia.
I terreni vulcanici infatti risultano essere ricchi di sabbia e tale ricchezza fa si che non venga trattenuta abbastanza umidità. Le larve di fillossera hanno bisogno di terreni umidi al fine di muoversi e scavare gallerie e, pertanto, in questi terreni la riproduzione dell’afide risulta impossibile. Altre motivazioni sono dovute alla scarsa presenza di argilla che la fillossera predilige per il suo ciclo vitale e l’elevata presenza di minerali. Zorro, ferro e gli altri minerali di cui questi suoli sono ricchi non sono amati dall’afide.
In Italia oggi terreni vulcanici come l’Etna presentano viti a piede franco prefillossera con età anche superiore ai 100 anni, testimonianza viva della forza della natura in grado di opporsi a qualsiasi calamità.
Terreni sabbiosi
Altro terreno in cui l’insetto non riesce ad attecchire è il terreno sabbioso. Questi tipi di terreni infatti drenano molto rapidamente l’acqua creando un ambiente secco che, come detto prima, impedisce alla fillossera di riprodursi e alle eventuali larve di scavare gallerie e muoversi liberamente.
Inoltre nei terreni sabbiosi, le viti tendono a scavare in profondità il terreno alla ricerca di acqua, portando le proprie radici sempre più in basso. L’area di attacco della fillossera è quella superficiale e pertanto, non trovando radici da attaccare, risulta impossibile per l’afide trovare il sostentamento per il suo ciclo vitale.
Economia del vino: come l’elevato valore del vino ha spinto a innovazioni tecnologiche
Come abbiamo avuto modo di vedere, il vino sin dai tempi più antichi ha sempre avuto un ruolo chiave nell’economia globale con un valore che si estende ben oltre la semplice commercializzazione del prodotto. La viticoltura infatti oggi rappresenta una delle principali attività agricole in molti paesi, specialmente in Italia, Francia, Spagna, Stati Uniti e Argentina. Essa genera valore per agricoltori, viticoltori, enologi e lavoratori nelle cantine.
Il vino, inoltre, risulta essere uno dei prodotti agroalimentari più esportati al mondo, creando profitti di miliardi di euro per paesi come Francia e Italia. Altro aspetto economico da non sottovalutare è il turismo enogastronomico che ogni anno fa registrare milioni di visitatori, influenzando positivamente ristoranti e hotel.
Il vino coinvolge diverse industrie, tra cui la produzione di bottiglie, tappi, etichette, macchinari agricoli e logistica. Proprio questo profondo potere economico ha spinto nei secoli contadini e produttori a una continua innovazione tecnologica in ogni fase della filiera produttiva, dalla coltivazione della vite fino alla distribuzione e commercializzazione.
Eredità della fillossera: studi e innovazioni contro le nuove minacce
Oggi le sfide per la viticoltura sono molteplici: il cambiamento climatico in corso e la presenza di nuovi parassiti e nuove malattie (come la flavescenza dorata che sta devastando i vigneti veneti) spinge i moderni enologi ad arginare tali calamità al fine di continuare a produrre qualità ed eccellenza.
Nel campo tecnologico, ad esempio, risulta essere sempre più diffuso l’uso di droni e di immagini satellitari al fine di monitorare lo stato di salute delle viti in modo da prevenire siccità e malattie. Inoltre l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e lo studio di dati raccolti permette di prevenire le malattie in base ai cambiamenti climatici e ambientali.
La genetica dal canto suo sta invece donando informazioni chiave sulle varietà più resistenti ai cambiamenti climatici e alle malattie. La robotica invece fornisce macchinari sempre più all’avanguardia rendendo azioni come la potatura e la raccolta più rapide e sostenibili. Nuove tecniche di biocontrollo si fanno sempre più strada nella prevenzione di nuove malattie. Tali tecniche prevedono l’uso di insetti antagonisti o funghi benefici per combattere patogeni.
Sempre al fine di proteggere la vite nel modo più naturale possibile, oggi si è incrementato l’utilizzo di rame e zolfo nei terreni. Inoltre nuovi sistemi di coltivazione si stanno facendo strada. Un esempio tangibile è rappresentato dall’adozione di coperture vegetali e agricoltura rigenerativa per migliorare il suolo e prevenire malattie. Malattie e calamità hanno inoltre stimolato la ricerca sviluppando moderne tecniche come la gestione della chioma, il diradamento dei grappoli e la rotazione delle colture migliorano la salute della vite.
Viticoltura: una storia d’amore infinita

“E guarirai da tutte le malattie perché sei un essere speciale ed io, avrò cura di te”. Sono proprio queste nobili parole di Franco Battiato che oggi rispecchiano in maniera completa questa millenaria storia d’amore. L’uomo e la viticoltura sono infatti uniti da un legame indissolubile, un legame che è sopravvissuto al tempo e allo spazio riuscendo ad attecchire nei terreni più impervi e a sopravvivere durante le crisi più nere.
La viticoltura moderna, come precedentemente descritto, si appresta a vivere numerose nuove sfide, nuove malattie, nuove crisi e nuovi cambiamenti climatici. L’amore è il motore del mondo ed è proprio questo sentimento profondo che lega questo binomio uomo/vite che riuscirà a sovrastare i momenti bui, creando terreno fertile per il sorgere del sole nei meravigliosi vigneti mondiali.