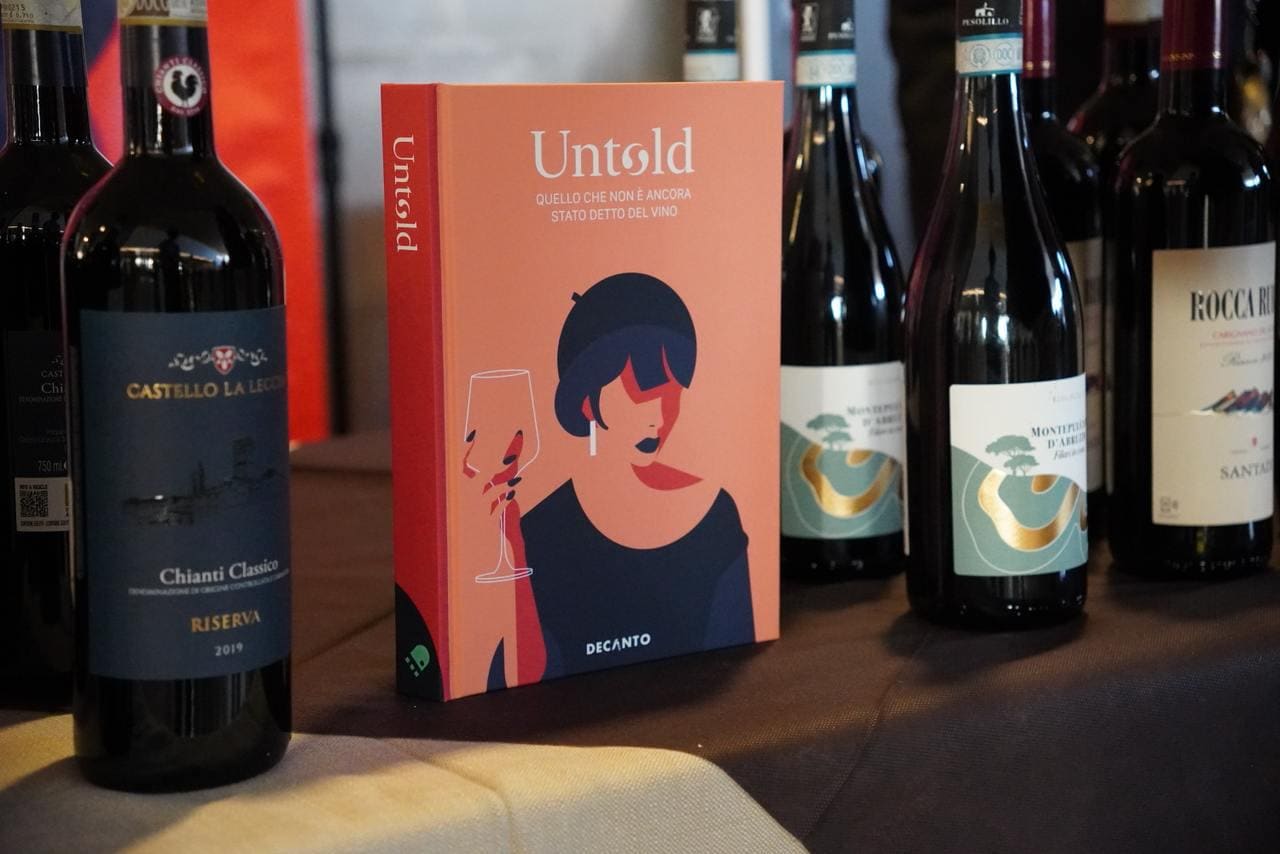Spumanti italiani: è vero, non siamo la prima patria dello spumante, non siamo la Francia, non abbiamo il leggendario Dom Perignon a trainare il marketing e non abbiamo inventato la rifermentazione in bottiglia, ma questo, in realtà, non significa nulla. L’Italia è un Paese che può vantare comunque una grande tradizione spumantistica ed è un Paese in cui si producono vini spumanti in tante aree storicamente vocate, tutte diverse fra loro e tutte con una storia straordinaria. Vediamole insieme.
Gli spumanti dell’Oltrepò Pavese
Forse è una delle zone storiche di produzione di spumanti meno conosciute. I vini spumanti dell’Oltrepò Pavese spesso sono difficili da trovare sia in enoteche sia nelle carte vini, anche di ristoranti prestigiosi (grave demerito!). Eppure, lo si può dire con assoluta certezza, gli spumanti dell’Oltrepò Pavese sono famosi e richiesti per la loro particolare composizione, che prevede, nei casi specifici del disciplinare di cui parlerò più avanti, la prevalenza del Pinot nero, che proprio in questa zona d’Italia ha trovato un territorio adatto alle sue necessità e alla sua piena espressività.
Come in tutta la nostra penisola, anche qui le testimonianze sulla presenza della vite e sulla coltivazione del vino risalgono indietro nel tempo fino a spingersi al primo secolo a.C.: a quest’epoca risalgono le parole di Strabone, geografo e storico greco, che di passaggio in questi territori, a proposito del vino, scrisse: “un vino buono, popolo ospitale e botti in legno molto grandi”.
Certo, per parlare di spumante dobbiamo ovviamente fare riferimento a tempi più recenti: in Oltrepò pavese sono ancora presenti cantine storiche ha hanno segnato la produzione spumantistica della zona in tempi non sospetti. È infatti nella seconda metà dell’800 che il Conte Augusto Giorgi di Vistarino portò proprio in Oltrepò delle barbatelle di Pinot nero dalla Francia, gettando così le basi per la produzione di spumante italiano.
Ci furono poi vicende alterne, prima di arrivare alla vera grande svolta del 1904, quando fu creata la Società Vinicola Italiana Casteggio con il chiaro e definito obiettivo di produrre spumante italiano metodo classico. E anche se durante la prima guerra mondiale la società si sciolse, molti altri portarono avanti singolarmente la produzione di spumante, fino ad arrivare al raggiungimento del certificato di eccellenza con l’istituzione della DOCG nel 2007 (già DOC dal 1970).

Il Disciplinare dello spumante Oltrepò Pavese
Secondo quanto previsto dal disciplinare, sono previste quattro tipologie di spumante: Oltrepò Pavese metodo classico, Oltrepò Pavese metodo classico rosé, Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero e Oltrepò Pavese metodo classico Pinot nero rosé.
Come si diceva prima, il protagonista dello spumante italiano prodotto nella zona dell’Oltrepò Pavese è il Pinot nero e infatti per le prime due tipologie il disciplinare prevede una percentuale minima del vitigno pari al 70%, cui si possono aggiungere congiuntamente o meno Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco. Per le altre due tipologie, in cui è espressamente menzionato il vitigno, la percentuale sale a un minimo dell’85%, cui, come per gli altri due, si possono aggiungere Chardonnay, Pinot grigio e Pinot bianco.
Per la vinificazione, e in particolare per la permanenza sui lieviti in bottiglia (abbiamo parlato del processo di rifermentazione in bottiglia in questo articolo), il disciplinare prevede un minimo di 15 mesi, che diventano 24 nel caso dei millesimati, cioè degli spumanti prodotti con uve di un’unica annata.
Spumanti dalla Franciacorta
Ci spostiamo ora, ma non di molto; restiamo nella stessa regione di produzione degli spumanti dell’Oltrepò Pavese, ma ci dirigiamo verso il Veneto, e, dalla provincia di Pavia, arriviamo fino alla provincia di Brescia. Qui, tra le sponde meridionali del Lago d’Iseo inizia la storia di uno degli spumanti italiani più conosciuti e diffusi su tutta la penisola: sto parlando del Franciacorta DOCG.
La storia dello spumante qui si lega indissolubilmente alla storia del nome di questo territorio: l’origine del nome “Franciacorta” deriva, con ogni probabilità, da “Francae Curtes”, cioè territori non soggetti a dazi, a tasse, e quindi “corti franche” appunto, gestite e amministrate da monaci cistercensi che nell’XI secolo si spostarono da Cluny in Franciacorta e fondarono monasteri importanti che riuscirono a ottenere l’esenzione dal pagamento dei dazi grazie a i lavori di bonifica e coltivazione del territorio.
Il primo documentato riferimento ai vini con le bollicine prodotti in questo territorio risalgono al 1570, quando venne pubblicato il Libellus de vino mordaci del medico bresciano Girolamo Conforti che racconta dell’ampia diffusione dei vini “mordaci”, cioè briosi, con le bollicine, in quel periodo e dei loro benefici sulla salute dell’uomo.
Più tardi, saranno i documenti napoleonici a fornire un’istantanea della grande diffusione della coltivazione della vite in Franciacorta, di cui circa mille ettari erano destinati proprio alla produzione di vini “mordaci”, quindi spumanti.
Ma la vera svolta per la produzione professionale e sistematica degli spumanti metodo classico di Franciacorta si deve senza ombra di dubbio a Franco Ziliani, enologo di Guido Berlucchi, che negli anni ’60 del secolo scorso diede ufficialmente l’avvio a una nuova storia degli spumanti italiani, culminata nel riconoscimento della DOC nel 1967 e della DOCG, prima volta per uno spumante metodo classico in Italia, nel 1995.
Il Disciplinare dello spumante italiano Franciacorta DOCG
Che cosa dice il disciplinare in merito alla produzione di Franciacorta? Forse non tutti sanno che proprio questo spumante prevede una particolare tipologia produttiva unica nel panorama spumantistico italiano: la versione Satén. Ma andiamo per gradi.
Per la produzione di spumante metodo classico Franciacorta DOCG, le tipologie ammesse sono tre: Franciacorta, Franciacorta Satèn e Franciacorta Rosé. Per ciascuna tipologia il disciplinare impone che la permanenza minima sui lieviti sia così distribuita: per il Franciacorta 18 mesi, per il Franciacorta Satèn e Rosè minimo 24 mesi; per la versione millesimata di ciascuna tipologia minimo 30 mesi, che salgono a 60 per la versione Riserva (ammessa per ciascuna tipologia).
Quanto ai vitigni, poi, per ciascuna tipologia il disciplinare stabilisce percentuali diverse e più o meno vitigni ammessi: per il Franciacorta sono utilizzabili Chardonnay e Pinot nero in misura non definita, cui si può aggiungere per un massimo del 50% il Pinot bianco e per un massimo del 10 % l’Erbamat, vitigno autoctono del territorio; per la versione Rosè è ammesso lo Chardonnay fino al 65% e il Pinot nero almeno nella misura del 35%, restano invariate le percentuali di Pinto bianco e Erbamat. Per la versione Satèn, invece, il produttore può usare solo Chardonnay per un minimo del 50% e Pinot bianco per un massimo del 50%. Una delle due caratteristiche principaydel Satèn è infatti quella di essere fatto solo con uve a bacca bianca.

Altra particolarità che contraddistingue il Satèn rispetto alle altre tipologie, sia nella versione classica, sia millesimata, sia riserva, è la pressione massima consentita che è di 5 atm, questo consente di regalare al palato bollicine più cremose e avvolgenti. Inoltre è previsto, quanto al residuo zuccherino, solo nella tipologia Brut.
Trento e gli spumanti di montagna
Panorama spumantistico italiano dalla fama indiscutibile, la realtà del Trentodoc oggi non è solo quella di un disciplinare, ma, dal 2007, di un marchio collettivo territoriale.
La storia delle cosiddette “bollicine di montagna” trova una sua articolazione a partire dalla metà dell’800, periodo a cui risalgono le prime produzioni di spumante. Le successive tappe che segnano dei veri e propri snodi nella storia di questo mirabile esempio di spumante italiano sono quattro. Nel 1874 nasce l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige che sarà luogo di studio e formazione di importanti enologi e primo fra tutti di colui che più di tutti determinò lo sviluppo di questa zona come zona a vocazione spumantistica: Giulio Ferrari. È grazie a lui che nel 1902 inizia la produzione di spumantistica classica nella zona del Trentino. Un terzo passo decisivo è rappresentato dal riconoscimento della DOC Trento nel 1993 cui si aggiunge in tempi più recenti la trasformazione dell’Istituto Agrario di San Michele all’Adige in Fondazione Mach, avvenuta nel 2008.
Come si producono le bollicine di montagna?
Uno degli aspetti singolari di questi spumanti è dato dall’avere una loro vera e propria carta d’identità. Il sito del Trentodoc ci informa che “Da una ricerca della Fondazione Mach e del Ministero dell’Agricoltura, è emerso un dato molto interessante: se un metodo classico contiene un numero consistente di specifici composti volatili, generati grazie alle escursioni termiche tipiche degli ambienti montani, significa che quel vino non può essere altro che un Trentodoc. Così la montagna imprime la propria firma.”
La cifra stilistica distintiva del Trentodoc è proprio la montagna, con il suo clima, le sue altitudini e le sue escursioni termiche.
Stando al disciplinare di produzione, le versioni previste per lo spumante metodo classico “Trento” sono “bianco” o “rosato” e le uve ammesse per la produzione sono Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Meunier.
Il tempo di permanenza sui lieviti previsto deve essere di almeno 15 mesi, che salgono ad 24 per il millesimato e a 36 per la riserva, ma in moltissimi casi i produttori optano per “riposi” più lunghi, in modo da garantire maggiore complessità e qualità.
Non solo metodo classico: il caso “Prosecco”
Il più esportato e forse anche il più imitato degli spumanti italiani è il celebre “Prosecco”, parola che spesso nell’immaginario italiano, colpa una comunicazione del mondo del vino a più livelli un po’ troppo superficiale, è stata associata tout court alle “bollicine”: chiunque chiedeva o, peggio ancora, proponeva un “prosecco”, proponeva uno spumante, senza intendere pienamente che cosa queste due parole – spumante e prosecco – volessero effettivamente significare.
Il Prosecco è sì uno spumante, ma prodotto con Metodo Martinotti, che non è il Metodo Classico – vi abbiamo raccontato tutte le differenze della spumantizzazione in questo articolo.
Ed è proprio grazie alla Regia Scuola Enologica di Conegliano che il Prosecco è quello che oggi conosciamo.
Che cosa dice il Disciplinare di produzione
Oltre a definire la zona delimitata e circoscritta in cui si può produrre “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” DOCG, come elemento di base irrinunciabile e costitutivo della tutela di una produzione, il disciplinare ci informa su tipologie e su vitigni ammessi alla produzione.
Quanto alle tipologie, possiamo trovare: “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco”, “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco frizzante”, “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco spumante”, accompagnato dalla menzione superiore. Si può trovare anche la menzione “Superiore di Cartizze” solo se prodotto appunto nella sottozona di Cartizze.
Il vitigno è la Glera, che può essere accompagnata al massimo per il 15% – ma molti produttori usano sempre più spesso Glera in purezza – da altri vitigni autoctoni a bacca bianca come Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga.
Infine, per la versione spumante – ricordiamo, realizzata con Metodo Martinotti e quindi rifermentazione in autoclave – il disciplinare ammette anche uve Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Chardonnay, da sole o congiuntamente, sempre nel limite del 15%.
Una nota importante meritano le cosiddette “Rive”, che nel gergo locale indicano le pendici delle colline scoscese tipiche della zona di Conegliano Valdobbiadene. Quando si trova questa dicitura in etichetta significa che lo spumante è stato prodotto esclusivamente con uve provenienti da un unico comune o frazione di esso, per esaltare le caratteristiche che il territorio conferisce al vino. In totale ce ne sono 43.
Inoltre nel 2020 il Consorzio ha pubblicato uno studio volto a distinguere in modo più marcato e peculiare il territorio di Conegliano Valdobbiadene. Ne è derivato un volume che, come scrive lo stesso Consorzio “raccoglie 19 storie, quante sono le sottozone analizzate, in ognuna di esse il viticoltore può trovare i tratti caratteristici del singolo appezzamento che possono restituire la giusta autorevolezza al vigneto e così rompere l’omogeneità della Denominazione”.
Altri spumanti sparsi per l’Italia
Non bisogna dimenticare zone di produzione come l’Asti DOCG, che vanta uno degli spumanti più riconosciuti ed esportati all’estero, il celebre Asti Spumante, che ha saputo conferire al Moscato Bianco, vitigno aromatico, una sua definizione inconfondibile.
E certo vantano un primato inconfutabile anche i Lambruschi. Sì, perché non esiste un solo Lambrusco dell’Emilia, ma ce ne sono addirittura sei riconosciuti, o meglio, sei DOC con le loro varietà e differenze: Reggiano, Modena, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Colli di Scandiano e di Canossa, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco di Sorbara. Un universo di bollicine in cui divertirsi a esplorare e scegliere tra tanti gusti diversi.
Va detto anche che come tendenza dell’ultimo decennio tutte le regioni d’Italia con le loro migliaia di cantine spesso hanno iniziato a spumantizzare, cercando di inserire all’interno della loro offerta anche uno spumante: non è quindi ormai insolito poter bere spumanti, anche se non prodotti in zone di storica vocazione spumantistica, dalle Valle D’Aosta fino alla Sicilia.